Ligabue è il cantante di provincia che non siamo riusciti a cambiare, ed è stato tutto merito suo
La prima volta che è quasi morto, Luciano Ligabue non era ancora nato. Il cordone ombelicale gli si era attorcigliato intorno al collo mentre sua mamma lo partoriva, e più spingeva e più lo strangolava. La seconda, a un anno e mezzo, è quasi morto di peritonite. La terza, a cinque anni, di tonsillite. Più precisamente, è quasi morto soffocato da un’emorragia poco dopo che gli avevano asportato le tonsille. A donargli il (molto) sangue che aveva perso era stata la stessa suora che aveva provato a mandar via sua madre dopo l’operazione, naturalmente senza riuscirci.
La voce strozzata se l’è portata dietro per tutta la vita, insieme al rischio di perderla per sempre. E così anche il sangue a fior di pelle, con le vene sempre gonfie, quasi ostruite.

Quando il suo manager di sempre, Claudio Maioli – Il Maio –, capì che c’era ciccia per gli affari, gli disse che dovevano fare un patto di sangue. Lui, LL, gli rispose: “Va bene, basta che mi fai fare un concerto al giorno e io ti do tutto il sangue che vuoi, anche se forse non ti piacerà perché è un po’ di suora”. Era il 1987, LL aveva 27 anni, che nella musica da lui più amata era stata un’età fatale per alcuni tra i più grandi, e ci provava da un po’, ma aveva ancora tutto da cominciare. C’era sempre qualcosa, delle sue canzoni, che non convinceva quelli ai quali le proponeva. Un eccesso, una melensaggine, un’ingenuità, un’ostentazione. Troppa provincia, troppa Correggio, troppa Inter, troppe note. Era troppo pop per essere rock e troppo rock per essere pop.
Ma quella sera dell’87 suonò come non aveva suonato mai: s’era stufato dei no e dei forse, e gli era salita la garra. Cos’è la garra lo spiegano bene su L’Ultimo Uomo, usando una frase che disse Jules Rimet, un dirigente sportivo francese morto a metà degli anni Cinquanta, dopo il Maracanazo, quando l’Uruguay batté il Brasile e vinse i Mondiali: “Nel calcio, giocare bene a volte non basta. Devi anche farlo profondamente, come fa l’Uruguay”. E aggiungono: “Ha la garra chi dà il meglio di sé in situazioni vivi-o-muori, chi sputa sangue”. Ligabue è sopravvissuto a quella emorragia sputando sangue, e ha scritto una canzone che si chiama “Vivo o morto o X” che in due versi dice come si viene al mondo: “Nato da un sospiro o da un temporale, l’ostetrica ti batte e non ti chiede come va”. Alle audizioni di XFactor di quest’anno s’è presentato un diciottenne di Bologna, con i capelli corti e la faccia da capellone, che dopo aver cantato “Grande figlio di puttana” degli Stadio ha detto di avere la garra. Non ha passato le selezioni, era imperfetto, acerbo, poco convincente. Come Ligabue, che colpiva ma non affondava, e aveva sempre qualcosa che gli mancava, che lo guastava, e anche se ha passato gli ultimi trent’anni della sua vita a far canzoni e concerti, libri e film, sempre con grande successo a parte un paio di volte ma proprio un paio, è ancora così: imperfetto, rovinato, per alcuni infelici pochi è persino un bluff.

Non manca mai, nei suoi pezzi, un tarlo, una sbavatura, una dialettica tra guasto e riparazione, vetta e abisso, pozzanghera e tombino, Francesco Guccini e Biagio Antonacci, un margine perfettibile che però è chiaramente inarrivabile. Nella stessa canzone, Ligabue è in grado di scrivere “Gli occhi han preso il colore del cielo, a furia di guardarlo”, che è un verso imbarazzante anche per un disco di Clementino, e “Sole e pioggia neve tempesta sulla valigia e nella tua testa e gambe per andare e bocca per baciare”, che è un verso d’altro livello, country e bellissimo. Fa ancora e ha sempre fatto canzoni piene di errori, incertezze, tamarrate, assoli che quando finiscono producono qualcosa di più del sollievo – uno dei momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo è “Quando l’assolo della chitarra elettrica finisce”. In tutte c’è però anche sempre qualcosa di potente e limpido, esatto, preciso, qualcosa di imbattibile che poteva dire e suonare soltanto lui, in quel suo modo che è sempre da prima o da ultima volta. Ligabue ha questo, del rock: l’evento. La sensazione di una cosa detta in punto di morte, di una saggezza giovane che quindi è intuizione e non consapevolezza, e non c’entra con l’esperienza.
Ligabue ha cominciato a fare il rock, anzi il rock’n’roll, quando non ci credeva quasi più nessuno, e gli anni Ottanta prescrivevano di farsi i fatti propri, e la vita era da bere, godere, aspirare. Aveva visto tramontare le radio libere e il Settantasette, e aveva scelto di non accettarlo.

Nel suo primo disco lo cantava chiaramente: “Non è tempo per noi che non ci adeguiamo mai, fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori dai, troppo ingenui o testardi, poco furbi caso mai, non è tempo per noi e forse non lo sarà mai”. Ed è vero che non s’è adeguato mai, e non perché abbia fatto musica d’avanguardia, anzi, ma è rimasto fuori dal tempo, è rimasto identico, coi bracciali, la giacca con le frange, gli stivali a punta, gli occhiali a goccia, il parlare di vene e sangue e passione, Elvis e Correggio sempre addosso, duro e testardo come una pietra, che il rock questo è, prima d’ogni cosa, una pietra. Ligabue non s’è reinventato mai, ha detto sempre le stesse cose, e quando è sembrato dirne altre è stato perché le ha scritte con altri occhi, altri anni addosso, cresciuto, certe volte anche invecchiato. Ha detto sempre le stesse cose, che nella vita conta l’amore prima di tutto, e subito dopo e a pari merito il vino, le donne, i concerti, i bar e certe notti; che si sta bene seduti in riva al fosso; che resistere serve a tutto; che l’onestà è importante; che i sogni sono un diritto e anche un dovere; che la schiena dritta sta su un culo dritto; che il successo è un soffio e bisogna sempre, sempre “giocare generosi” perché s’agisce in squadra; che bisogna sempre andare. Lo ha fatto senza troppi tormenti, senza intoppi, guardando la vita da un posto fortunato, da mediano innamorato degli altri, ficcanaso rispettoso, bambino e poi adulto sempre molto amato da affetti stabili. Niente stramberie in famiglia e neanche fuori dalla famiglia, e forse è per questo che le ha cercate fuori, e dei pazzi che s’incontrano nelle piazze e nei bar ha riempito dischi interi.
L’autobiografia in cui ripercorre i trent’anni della sua carriera è appena uscita per Mondadori, si chiama “E’ andata così” e l’ha scritta insieme a Massimo Cotto, giornalista, che nell’introduzione ricorda quella frase che

Sean Penn dice in “This Must be the Place” di Sorrentino, “il vero problema è che passiamo senza neanche farci caso dall’età in cui si dice farò così all’età in cui si dice è andata così”, e poi osserva: “Luciano Riccardo Ligabue è uno dei pochi che potrebbero pronunciare entrambe le frasi senza frustrazione o senso d’incompiutezza”. Soltanto a LL poteva riuscire di scrivere un libro con uno che lo venera, loda e glorifica per trecento pagine, senza risultare né megalomane, né egocentrico, ma soltanto provinciale. Provinciale nel modo salutare che è riuscito solamente a lui. E veloce nel modo che è riuscito solamente al Settantasette. In “Radiofreccia”, il suo primo film, Bruno Iori, uno dei protagonisti, dice a un certo punto: “Non so se il Settantasette sia stato brutto o bello, però è stato veloce”. Quel film glielo chiese Domenico Procacci, lui era già il Liga, gli anni Novanta stavano finendo: gli telefonò e gli disse che voleva un film sulla provincia italiana come l’aveva cantata e soprattutto scritta lui nel suo primo libro, “Fuori e dentro il borgo”. Lui accettò, ci mise dentro quel libro, il bar, gli amici, le radio libere, tutto il mondo che non esisteva più e che in provincia, anche se lo si era soltanto annusato e sognato, continuava a sentirsi, a incidere su un destino, a entrare in una canzone, a istruire una vita. In fondo questo è la provincia italiana che ha raccontato Ligabue: un posto dove i sogni vengono protetti dalla realizzazione, e si può essere santi, Elvis, poeti, drammaturghi semplicemente dicendo di esserlo, per una notte o per un anno o per sempre. In Radiofreccia c’era anche Guccini, che fece la parte del barista, e si fece pagare in vino.
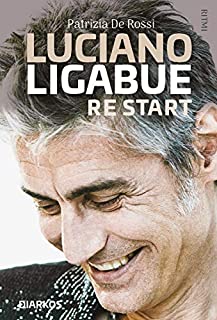
“E’ andata così”, una vita su e giù da un palco, fortunata, sana, accesa, una vita che gli ha permesso di bruciare da due lati, di amare una donna, la prima moglie, Donatella, perché “sempre pronta e sempre ingorda, sempre e solo come vuoi” e di cantarle, dopo che si erano separati, che “E’ andata come poteva come doveva”, che è una frase d’amore per un amore passato che soltanto un interista poteva scrivere, ché si sa che lo zen è l’arte di tenere all’Inter.
Come i russi e gli interisti, Ligabue non s’è mai opposto al destino. Gli è toccata Correggio, e a Correggio ha imparato a stare. Gli piaceva Elvis, e anziché andare e rincorrerlo a Las Vegas, lo ha cercato lì e lo ha trovato nei bar, e ha raccontato il travestimento e l’ambizione che rappresentava. Ha avuto più garra che talento, e lo ha ammesso in “Una vita da mediano”, che è una delle sue canzoni migliori, una delle migliori canzoni di sempre sul successo e sul fallimento e sulla vita che ci sta in mezzo: “Una vita a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni lavorare sui polmoni; una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco; una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatica e botte e vinci casomai i Mondiali”. Gli hanno rimproverato d’essere un rocker annacquato, e per rendere il rimprovero efficace lo hanno infilato in una competizione con Vasco Rossi, perché vuoi mettere “Susanna” con “Bambolina e barracuda” e “Vita spericolata” con “Certe notti”, senza capire o senza voler ammettere che la vita dove non è mai tardi a un certo punto diventa un incubo, non è democratica, non è per operai e non è per cantanti, richiede fatica e sforzo e soldi, mentre “certe notti con la radio che passa Neil Young e sembra avere capito chi sei” sono di tutti, capitano a tutti, e per finire tra cosce e zanzare non c’è bisogno d’essere eroi invincibili. Gli hanno rimproverato di piacere a tutti perché non portava mai un vero tormento, proprio lui che è cresciuto nell’Emilia paranoica dei CCCP, lui che la prima volta che ha annullato un concerto per colpa di una febbre altissima e violenta vagava per la casa con una coperta addosso e sentiva dei rumori dal piano di sopra, dove abitavano i genitori di Pier Vittorio Tondelli, e quei rumori erano Tondelli che moriva. Era il 1991 e lui aveva pubblicato pochi mesi prima “Lambrusco coltelli rose & pop corn”, il suo secondo disco a un anno dal primo, “Ligabue”, che aveva fatto una fatica enorme a piazzare, perché “volevano le tastiere, non le chitarre”.

“E’ andata così” e il solo cruccio che ha avuto davvero, per tutta la vita, è stato il successo: lo merito, non lo merito, mi piace, non mi piace, mi contaminerà. La voce strozzata se l’è portata dietro per tutta la vita, insieme al rischio di perderla per sempre. E così anche il sangue a fior di pelle.
Ha sempre fatto canzoni piene di errori, incertezze, tamarrate, assoli che quando finiscono producono qualcosa di più del sollievo.
L’autobiografia in cui ripercorre i trent’anni della sua carriera si chiama “E’ andata così” e l’ha scritta insieme a Massimo Cotto…. Al terzo disco ci è arrivato da campione, e però ci ha messo dentro “Ho messo via” e “Ancora in piedi” e “Piccola città eterna” e “Quando tocca a te”, tutti pezzi che raccontavano la costrizione del dover essere per gli altri, di doversi ingrandire, allargare, di dover fare posto alla vita nuova, di non commettere errori, o almeno di commetterne di nuovi. Dieci anni dopo, insieme a Francesco Guccini ha scritto “Ho ancora la forza” e ha messo in quel pezzo chi è sempre stato e chi è rimasto: “Ho ancora quella forza che ti serve quando dici: si comincia! Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c’è e al mondo sono andato dal mondo son tornato sempre vivo”. Non siamo riusciti a cambiarlo. E lo avremmo voluto tanto e ancora lo vogliamo e infatti in questi giorni Dagospia ha messo in circolo una voce che lo vuole omosessuale, e certi giornali hanno scritto che “è caccia” all’artista che sembra lui e che bacia un uomo in stazione. Come se questo potesse spostarlo dalla sua riva del fosso. Dalla sua Correggio. Edmondo Berselli scrisse che il Liga aveva una vita almeno doppia: stava bene nel suo paesino, amato e non disturbato da tutti, e stava bene nei circuiti industriali e commerciali dello showbiz. Scrisse che il suo segreto era “il segreto dell’Emilia, il luogo fisico e mentale in cui sono cresciuti anche Zucchero e Bertoli: la capacità di stare bene con le proprie radici, nella materialità conosciuta, nella propria terra, abituandosi immediatamente ai processi e ai luoghi della realtà postmateriale”. Lo definì “un tipico abitante di un paese mondo”.
Dev’essere stato anche merito del sangue di suora, e di quella misericordia, di una bontà che oggi il rock ha, forse perché è lontano, antologizzato, archeologico.
Al funerale di Mario, il Mario di quel bar Mario che un po’ è esistito nelle canzoni del Liga e un po’ è stato inventato dalle canzoni del Liga, il giornalista della Gazzetta di Reggio che andò a scrivere un pezzo, s’accorse che nel locale, sulla bacheca delle foto, ce n’era una di Mario e una bellissima, sorridente suora. I ragazzi sono in giro, e pure le suore.
Articolo di Simonetta Sciandivasci per il Foglio Quotidiano



